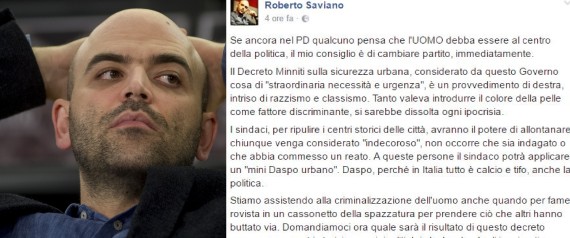“Lettera aperta dal confino
FABIO ACHAB·VENERDÌ 14 OTTOBRE 2016
Buongiorno a tutti,
Sono Fabio Gabaglio, ieri mattina mi è stato notificato un “foglio di via” da Como della durata di un anno. In questo atto mi si accusa di avere preso parte ad una manifestazione non autorizzata in cui si denunciava la complicità della ditta di trasporti Rampinini nella deportazione dei migranti, di essere una persona socialmente pericolosa e di frequentare la città di Como col solo scopo di compiere reati. Con questa lettera aperta, per chi avrà la pazienza di leggerla, io intendo spiegare il mio punto di vista, rivendicare pubblicamente il mio operato, la mia identità e produrre quella difesa politica che in altre sedi non mi è consentito di dare. La doverosa premessa è quella che fa dei lettori a cui mi rivolgo, dei “giudici impectori”, il cui giudizio è quello che maggiormente m’importa, supponendo che anch’essi, come me, si pongano propositi di cambiamento radicale della società, interpretando il presente come profondamente ingiusto. Dal luglio scorso, quando la città di Como si è trovata al centro di quella che è stata definita “emergenza migranti”, ho iniziato ad interessarmi a quanto stava accadendo tra il confine Italo-Svizzero e la stazione di Como san Giovanni. Una sorte ironica fece che tutto il mio tempo libero, ferie incluse, lo trascorsi in quello che è anche un mio luogo di lavoro, in quanto di mestiere sono Macchinista Ferroviere. La storia è nota, ma non è mai superfluo ripeterla: L’autorità doganale svizzera chiude quasi completamente le dogane ai numerosi profughi che tentano di attraversarla e ai richiedenti asilo che vi si vorrebbero insediare, e a Como si crea quindi un ingorgo e l’accampamento che tutti abbiamo conosciuto. Chi cerca di passare il confine viene respinto a piedi sul suolo italiano nel migliore dei casi, altrimenti viene deportato nei centri di smistamento del sud Italia, Taranto quasi sempre. Con alcuni sodali decido esprimermi e spendermi sulla questione dando un apporto politico all’enorme e meritorio sforzo civile che la città, la parte migliore della città, ha profuso per dare ai “Ragazzi” un’ accoglienza dignitosa, un trattamento umano e un sostegno materiale. Il mio proposito aggiuntivo è quello di animare il dibattito generale sulla questione migratoria, ponendo degli interrogativi politici sugli interessi che influenzano la gestione dei flussi ed evidenziando le innumerevoli contraddizioni che ne emergono. Iniziai cosi, implementando il lavoro quotidiano di centinaia di volontari, a produrre una critica che spingesse ad andare oltre il livello della necessaria accoglienza che da più attori viene messa in campo, per costruire una solidarietà diretta, capace di mettere in relazione la condizione dei migranti, vittime estreme del sistema economico in cui viviamo, e la nostra, di indigeni, esposti agli effetti della crisi e della conseguente precarizzazione totale delle nostre vite. Per farlo in modo organico, occorreva però toccare con mano le questioni, conoscerle a fondo, e mediante l’inchiesta, guadagnarsi la libertà di parola, il titolo di potersi esprimere a ragione veduta. La prima iniziativa per cui mi spesi in prima persona fu il 7 agosto, una giornata di giochi, sport e socialità. Bastarono quattro palloni, un paio di canestri da basket, e una merenda collettiva per scoprire che quello che ne sarebbe seguito sarebbe stato molto di più della semplice inchiesta politica, ma sarebbe diventato anche una relazione di profonda amicizia, di empatia, di auto-riconoscimento. Senza quasi rendersene conto il rapporto si strinse molto, il “noi” ed il “loro” si fusero, i nomi impronunciabili e forestieri divennero familiari, e quelli che rifiutammo di considerare “utenti-destinatari” della nostra elemosina divennero compagni delle nostre infinite giornate campali, narratori delle storie più incredibili, portatori della più legittima delle volontà. E noi ne diventammo complici. Si sperimentò un percorso di autogestione da cui nacque l’infopoint: un gazebo in cui si cercava di dare le principali informazioni pratiche e una primissima accoglienza materiale (cibo e vestiti) a chi arrivava al “campo informale”, si organizzarono corsi di italiano ed inglese, e ogni sera si tenevano riunioni interetniche tradotte in inglese, arabo, francese, tigrino, amarico, oromo… Fu in questo contesto di confronto virtuoso che si decisero le molte e diverse iniziative messe in campo, tra le quali la lettera aperta che i migranti scrissero alla città, il presidio tenuto a Pontechiasso, dove decine di migranti reclamarono il loro diritto di superare il confine e di non essere trattati da animali, e il corteo del 15 settembre, forse il più bello che nei miei trent’anni (molti dei quali vissuti da militante politico) possa ricordare, e per il quale personalmente chiesi l’autorizzazione alla questura. Quel corteo per me fu una scommessa: 500 persone dalle più diverse sensibilità ed esperienze, migranti in testa, veicolavano il messaggio lanciato dall’appello, “Il campo non è una soluzione, aprite il confine!”. Rimandate al al mittente le provocazioni dei fascisti che minacciarono costantemente la coda del corteo, disattese le aspettative allarmiste di chi paventava la calata dei barbari in città, dissolta la coltre di terrore imposta dallo sproporzionato spiegamento di militari, il corteo, fortemente comunicativo, sfilò per la città senza intoppi. La scommessa fu vinta. Il clima tuttavia cambiò repentinamente quando aprì il campo governativo, la non-soluzione sulla quale sollevammo tanti dubbi e contro la quale gli stessi migranti si sono sempre espressi. Nei giorni immediatamente precedenti alla sua apertura la solidarietà iniziò ad essere sempre più criminalizzata, cucinare o portare cibo divennero pretesti per far intervenire la polizia, le docce e la mensa vennero chiuse, e i migranti, in un paio di giorni, furono costretti a lasciare i loro ripari di fortuna per entrare nel campo governativo. I dubbi diventarono certezza quando la natura del campo governativo si manifestò in tutta la sua burocratica freddezza. Le garanzie date dal prefetto sul funzionamento del campo furono prontamente disattese, le richieste di modelli alternativi di accoglienza non furono accolte, le tutele specifiche per minori non vennero attuate, il regolamento interno non fu pubblicato, i volontari furono estromessi, e chi riponeva speranze nel “circuito legale dell’accoglienza” rimase amaramente deluso. Lo stato così ha ripreso il controllo della situazione anche fuori dal campo, tutto quello che prima era socialmente accettato e tollerato, ora è proibito. Distribuire cibo, incontrare, parlare con chi ha l’aspetto di un rifugiato, porta ad essere identificati, intimiditi, segnalati. Trovare un riparo di fortuna per chi non ha accesso al campo governativo è reso quasi impossibile dalle decine di pattuglie che ogni notte perlustrano ogni angolo di Como, ogni anfratto, con l’ordine di sgomberarlo, di rendere inospitale la città, cercando in questo modo di arrestare il flusso in arrivo. E su Como, la città bella e solidale che riscoprimmo quest’estate, cala un invernale clima di apartheid. Ora al sottoscritto, come ad altri attivisti, viene presentato il conto per il ruolo attivo tenuto in tutto questo. Il foglio di via, nella fattispecie, è una misura preventiva di natura fascista, in cui il questore, senza una vera e propria indagine, senza un processo e senza la possibilità di difesa, intima arbitrariamente al destinatario di non fare ritorno su un determinato territorio, riconoscendo in lui una presunta pericolosità sociale. La reale intenzione di chi emette questa misura non è tuttavia punire qualcuno per un reato specifico commesso, ma semplicemente colpirlo ed allontanarlo per le proprie idee e per le pratiche che potenzialmente ne derivano, isolandolo dai suoi percorsi di lotta e dal contesto sociale in cui è inserito. Nel mio caso, accade che ieri, 13 ottobre, mentre presenziavo in qualità di uditore alla conferenza stampa tenuta dalla rete di “Como senza frontiere” di fronte al campo governativo vengo avvicinato da alcuni funzionari di polizia che mi intimano di presentarmi in questura per notificarmi un foglio di via obbligatorio che mi inibisce dal fare ritorno nel comune di Como per un anno. Mi si contesta nello specifico di aver manifestato contro la ditta di trasporti Rampinini, che dal luglio scorso si occupa anche di deportare i migranti, che respinti in Italia dal confine elvetico, vengono caricati su dei pullman e, scortati da un ingente pattuglia di polizia, sono spediti nell’hotspot di Taranto, contro la loro volontà, senza avere contezza del loro status giuridico, interrompendo, mortificando e umiliando in maniera violenta il loro progetto migratorio, che per queste persone, rappresenta l’umana e innata pulsione a migliorare la propria condizione materiale. Per rimettere questa azienda davanti alla sua palese responsabilità di collaborazionista il 12 settembre si è tenuto un presidio simbolico davanti alla sua sede di via Napoleona, in cui si diffondeva un volantino e si esponeva uno striscione: Rampini complice delle deportazioni. Lo scrivevamo allora, lo ribadisco ora, assumendomi la responsabilità di quanto fatto. Se esprimere questo, senza chiedere il permesso a chi quelle stesse deportazioni le dispone e le realizza sia più vergognoso dello stesso compierle, lo lascio decidere a voi. Questo foglio di via mi descrive inoltre con l’infamante appellativo di “persona socialmente pericolosa”, che usa frequentare Como “col solo scopo di commettere reati” e di accompagnarmi a persone già oggetto di “segnalazioni all’autorità giudiziaria.” Io credo, che se vi sia una minaccia reale per la società, essa stia proprio nel fatto che certe dittatoriali limitazioni della libertà personale possano essere comminate a chi invece è parte integrante della società, a chi ne anima i moti di cambiamento, a chi ha la pretesa attiva di renderla più giusta, includente e civile. Essere riconosciuto come frequentatore abituale del campo informale della stazione è una cosa di cui non mi vergogno affatto. Farlo in concorso con altri solidali non ritengo sia un aggravante. Essermi riunito innumerevoli volte con dei migranti, averci discusso, essermi organizzato con loro per dare voce alle comuni istanze è una cosa di cui non sono in alcun modo pentito. Sfidare il clima di piombo che si respira in città per continuare a mantenere il rapporto con i migranti incontrati fino ad oggi, o per costruirlo ex novo con chi tuttora continua ad arrivare, non credo faccia di me un pericolo sociale. Ebbene, con questo foglio di via, la questura, l’apparato immunitario dell’ingiusto sistema politico-legale che abbiamo di fronte, pone nella mia vita un ostacolo giuridico che si frappone tra me ed i miei propositi che lascio a voi giudicare. La città di Como inoltre, come è normale che sia, per me, rappresenta anche un luogo fisico in cui si intrecciano interessi personali, abitudini, relazioni sociali ed affettive dalle quali ora con questo provvedimento si cerca di isolarmi in un assurdo accanimento. É lì che abitualmente trascorro il mio tempo libero, è lì che sono solito incontrarmi con amici e amiche, è lì che talvolta mi trovo a esercitare la mia professione, ed è lì che voglio liberamente poter tornare. Lungi dal voler elemosinare la pietà di alcuno, io credo che il mio dovere, a fronte di quello che mi è toccato, sia in primis mettere in guardia ognuno di voi: quello che oggi si abbatte su di me, domani potrebbe succedere ad altri. Quando il divario tra legalità e giustizia si fa così sfacciatamente evidente tutti sono chiamati a prendere una posizione. Ed è quello che io ora vi chiedo. Grazie della vostra attenzione. La parte più bella di questa città rifiuta il razzismo e l’indifferenza, e io sono (ancora) lì. Fabio Gabaglio ”
Il sito Informa-Azione riporta un comunicato di persone colpite dallo stesso provvedimento, nello stesso contesto, che annunciano resistenza contro le misure restrittive imposte dalla Questura.


 “Il 18 di Ottobre nel rio Chabut è stato ripescato il corpo di Santiago Maldonado.
“Il 18 di Ottobre nel rio Chabut è stato ripescato il corpo di Santiago Maldonado.