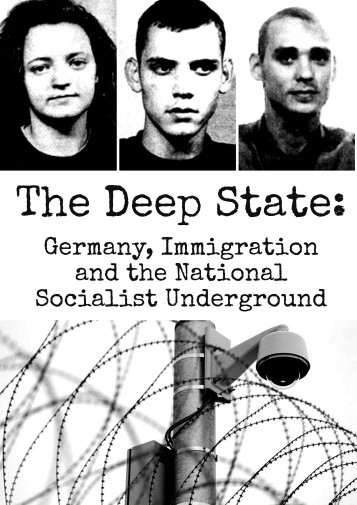Nils Christie, criminologo norvegese e teorico del riduzionismo penale, risponde in una intervista del 2002 ad alcune domande sul crimine nella società contemporanea, sui concetti di reato, criminale, punizione, sulle alternative al sistema giudiziario attuale e soprattutto al carcere come strumento punitivo. Sebbene i presupposti che muovono l’analisi di Christie non siano quelli dell’abolizionismo carcerario bensí quelli appunto del riduzionismo, le sue riflessioni dovrebbero interessare chiunque metta in discussione l’esistenza degli Stati e delle loro strutture giudiziarie-carcerarie e la concezione stessa di delitto-punizione. Un ottimo punto di partenza per un confronto delle idee su un tema trascuratissimo, ma di vitale importanza per una critica radicale dell’ideologia dominante e del sistema-Stato nel quale viviamo. L’intervista è tratta dal sito diritto.it :
” IL CRIMINALE NON ESISTE…
Nils Christie: contro il carcere e per un sistema alternativo di soluzione dei conflitti
***
Riportiamo lintervista del giornalista Zenone Sovilla (già pubblicata sul sito internet
www.nonluoghi.it) al criminologo norvegese Nils Christie, uno dei padri della teoria
riduzionistica in ambito penale. Il docente universitario, autore tra laltro dellopera
Il business penitenziario, spiega nellintervista come dietro al ricorrente e spesso
ingiustificato ricorso al carcere ed a sanzioni privative della libertà personale,si
nascondano interessi economici rilevanti, quali quelli della casta dei professionisti
dei conflitti (magistrati, avvocati, e non solo). Un business che coinvolge anche,
in particolare negli Stati Uniti e nel Nordamerica, società private a fini di lucro che
amministrano la funzione carceraria. Un business, ammonisce Christie, che potrebbe
prender piede anche in Europa.
(Manuel M. Buccarella)
di Zenone Sovilla
La vita nell’età neoliberista catalizzata dalla televisione che ci chiude in casa e ci sottopone a inquietanti bombardamenti sull’allarme criminalità, rendendoci tutti più soli e diffidenti verso gli altri. Le piazze e le strade che si svuotano la sera trasformandosi nel loro grigiore in un simbolo tragico delle nostre paure. Il cittadino terrorizzato che delega allo Stato la cura della sua angoscia invece di provare a ricostruire le reti sociali. Lo Stato come sistema di controllo/repressione sociale e il carcere come fiorente industria al suo servizio.
Nils Christie studia il controllo del crimine da oltre cinquant’anni e non ha dubbi sulla origine ambientale del comportamento “deviante” rispetto alle convenzioni sociali o alle leggi. In inglese è appena uscita una edizione ampliata del suo “Crime control as industry. Toward gulags, western style” (in Italia la precedente da Elèuthera: “Il business penitenziario. La via occidentale al gulag”, 1998). Da poco è uscito sempre per i tipi di Elèuthera “Oltre la solitudine e le istituzioni. Comunità per gente fuori norma” nel quale Christie descrive cinque esperimenti, in corso in Norvegia da trent’anni, che propongono un’alternativa alla solitudine e alla privazione della libertà cui gli stati costringono gli “anormali”.
Nella libreria del suo piccolo ufficio all’istituto di criminologia dell’Università di Oslo, il professor Christie ha una sorta di piccolo archivio cartaceo: fascicoli che intitolano “Prigioni negli Stati Uniti”, “Prigioni in Russia”, prigioni, prigioni, prigioni
“Il grande nemico dell’essere umano – mi dice quando gli chiedo del suo rapporto con i movimenti politici – è spesso lo Stato. Mi hanno appena chiesto un articolo sui <criminali pericolosi> e io ho risposto che allora non scriverò degli individui ma degli Stati. Se finisci in una prigione russa o americana, per esempio, è alto il rischio di non uscirne vivo o di uscirne distrutto dal punto di vista psichico, fisico e sociale. Lo Stato è un elemento decisamente pericoloso per la vita umana, specie nell’ambito del sistema penale. Per questo è fondamentale l’impegno per difendere la società civile: non è possibile assistere a un trend come quello americano che nel corso degli anni Novanta ha visto quasi raddoppiare il numero dei reclusi: due milioni (oltre 700 ogni 100 mila abitanti), molti dei quali poveri o scomodi per il potere. Questo significa che ormai si impiega il sistema penale per dirigere la popolazione, invece di assisterla con il welfare state. E il sistema penale non ha controparti: è difficilissimo ostacolarne la continua espansione in società come le nostre…”.
– In che modo si può tentare di incamminarsi verso un sistema alternativo di risoluzione dei conflitti e di approccio al crimine?
“C’è un piccolo saggio che scrissi parecchio tempo fa, <Il conflitto come proprietà>, nel quale mi chiedo chi detenga la proprietà dei conflitti: mi sembra tutt’altro che naturale che sia lo Stato. La proprietà deve appartenere ai protagonisti del conflitto. Da questo punto di vista, i giuristi si possono considerare dei <ladri professionisti>, perché rubano i conflitti alla gente”.
– Mi sta portando verso un’ipotesi di abolizionismo del sistema penale’ Come quella del suo collega olandese Louk Hulsman…
“L’abolizionismo va oltre le mie intenzioni, mi sembra poco realistico. Credo che da un lato vada trasferita a metodi di soluzione alternativi – sul modello del giudice di pace – la gran parte dei reati, ma che dall’altro si debba conservare un sistema di garanzie cui una delle parti (la più debole) possa ricorrere per evitare un accordo iniquo. Se io ti ho spaccato il naso con un pugno e poi tu – che sei socialmente più attrezzato e potente – pretendi da me, oltre alle scuse e alle spiegazioni, un risarcimento che mi renderebbe schiavo, devo poter optare per un normale processo in un’aula di tribunale. Insomma, non si tratta di gettare alle ortiche la forma di difesa dei diritti individuali sviluppata nel corso dei secoli; si tratta di migliorarla…”.
– In Norvegia esiste la Camera dei conflitti, un’istituzione alternativa al sistema penale. Che risultati sta dando questa esperienza?
“All’origine c’era il giusto proposito di trasferire – con l’accordo di entrambe le parti – le cause dal tribunale a un organo di soluzione consensuale del conflitto. Il problema è che le cause che finiscono al sistema alternativo sono decisamente troppo poche e di scarsa rilevanza. Allora chiedo: sulla base di quale diritto la Procura dello stato stabilisce che solo le piccole cause vanno alla Camera dei conflitti’ Qual è la ragione reale che impedisce il canale alternativo, per esempio, a casi seri di violenza, anche quando entrambe le parti, vittima e imputato, sono d’accordo? E’ per tutelare il potere della società. E perché le professionalità che qui entrano in gioco – magistrati, avvocati… – devono difendere i loro interessi, non possono accettare che la gente riesca ad arrangiarsi senza di loro…”.
– Trasferire più cause a un sistema di soluzione civile o comunitario, però, significa coinvolgere un numero crescente di persone chiamate a mediare fra le parti…
“Quando la sera cammino per le strade vuote di Oslo vedo dietro le finestre una luce blu. La dentro siede l’intera nazione e guarda la tv. Sarebbe stato molto meglio se, invece, quelle stesse persone fossero riunite in un’assemblea popolare per discutere di un omicidio”.
– In qualche zona del mondo succedeva. Anzi, forse succede ancora…
“In realtà è un metodo antico di risolvere le controversie. Per esempio, era comune che i più anziani della comunità si riunissero per cercare una soluzione a un conflitto. C’era questa consuetudine anche in Norvegia, nelle valli più remote: si cercava naturalmente di evitare il processo penale, perché sarebbe stato un trauma che avrebbe portato con sè nuovi conflitti. Se in un piccolo villaggio una persona viene punita dal Tribunale, questo fatto può accendere la miccia di una guerra civile: non si può. Ora questa tradizione va recuperata e ricreata in Nuova Zelanda, dagli indigeni australiani. La nostra civiltà postmoderna, che domina il mondo, riscopre all’improvviso qualcosa che aveva buttato via. Ma in Nuova Zelanda, per esempio, succede che la creazione di professionalità attorno agli strumenti alternativi appesantisce il processo: torna la domanda di prima: chi ha la proprietà dei conflitti'”.
– Nell’esperienza norvegese che tipo di reati vanno alla Camera dei conflitti?
“Si arriva al massimo ai piccoli furti nei negozi. I reati che implicano una pena detentiva sono esclusi: così vuole la Procura dello Stato. Così si continua a far danni sociali utilizzando il sistema penale. Se guardiamo, invece, ai conflitti che nascono fra le grandi società commerciali o industriali, ci rendiamo conto che si cerca sempre una mediazione per evitare il muro contro muro in Tribunale, una prospettiva che sarebbe deleteria, foriera di nuovi conflitti. Il concetto mi sembra elementare anche per i rapporti sociali. Dunque, semplicemente non lo si vuole capire”.
– Perché?
“Per un insieme di ragioni, credo. Per cominciare, lo Stato, ogni organizzazione statuale, vuole poter governare e giudicare gli individui; le professioni coinvolte, come ho già detto, vivono dei conflitti sociali e più ce ne sono meglio è; poi, abbiamo la nostra tradizione culturale così legata all’idea del castigo, alla quale, certo, si contrappone la corrente che sostiene il perdono”.
– Mi sembra un meccanismo perverso che alimenta il regime della delega al “sistema”, che favorisce la sottrazione di responsabilità ai singoli componenti della società e la perdita di consapevolezza sui doveri e sui diritti del vivere in comunità. In definitiva, un altro ambito organizzativo che sembra fatto apposta per allontanare l’individuo e la sua proiezione identitaria dall’incontro con gli altri…
“Rianimare la vita sociale, gli intrecci e i dialoghi fra le persone, mi sembra, infatti, uno degli effetti collaterali significativi di un percorso alternativo per la soluzione dei conflitti”.
– L’idea di fondo di questi percorsi alternativi è il superamento del concetto di pena. Ma in che senso?
“Sto scrivendo un libro che si intitola <Il crimine non esiste>. Esiste l’azione. Poi le va dato un significato. Era un individuo malato? Ineducato? Arrabbiato? O forse era mio figlio che aveva <preso in prestito> un po’ di soldi senza chiedermelo? Oppure si trattava di un delitto? Insomma, un reato da punire o un comportamento da capire? Quali sono le condizioni sociali che determinano la lettura di un’azione nell’una o nell’altra direzione? Se siamo favorevoli a una comunità civile fatta di individui responsabili, se abbiamo questa tendenza anarchica, allora dobbiamo impegnarci a organizzare la società in modo che le azioni siano viste come qualcosa di diverso da un <delitto>. Le azioni non sono, diventano. Questo vuol dire che non si potrà mai rispondere alla domanda: la criminalità aumenta? Il crimine dipende da che cosa in una data società viene considerato tale. Al massimo si potrà rispondere che è stato <registrato> un aumento di <reati> ma non si potrà dire che la criminalità <è> in aumento. La criminalità è un’opinione”.
– Un fenomeno culturale. Dobbiamo capire le azioni anche a prescindere dalle leggi di un dato momento e luogo…
“C’è forse qualcuno di noi che con i suoi atti non infrange la legge ogni tanto? No, il codice penale non ci aiuta a capire la criminalità. Siamo in una situazione in cui i politici hanno poco di cui discutere: persi gli ancoraggi ideologici, domina la filosofia del mercato e dei soldi. Chi propone approcci alternativi, come nel mio caso, non viene per nulla ascoltato. Dunque, non ci sono nella politica i portavoce dei valori sociali anti-sistema, non c’è chi <complica> il dibattito; intanto la criminalità diventa un buon terreno per riscaldare gli animi e mietere facili consensi. Questo è evidente in molti Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti: se hai l’immagine di un politico troppo debole sul fronte della criminalità, per te è finita; la maggioranza ti volta le spalle, sei amico dei nemici del sistema”.
– Considerato che una persona mediamente dotata d’intelletto dovrebbe rendersi conto di quanto sia facile finire fra chi infrange una qualche legge, come mai è così semplice manipolare l’opinione pubblica con l’allarme criminalità?
“Perché la stessa persona media di solito non riesce a identificarsi mai con una certa azione <criminale> – reati legati agli stupefacenti, per esempio – e pensa: questo non lo farò mai. Ora, questa mancata capacità di relativizzare, di tentare di capire le situazioni e i conflitti, è legata al crescente isolamento sociale, all’angoscia crescente, quella delle strade vuote di Oslo e delle finestre con la luce blu della televisione. La gente sta chiusa in casa. Guarda la tv e ha sempre più paura. A causa di quello che vede in tv ma anche perché fuori non c’è nessuno; fuori nel buio c’è solo la minaccia criminale. Ecco, allora, che quest’angoscia torna utile al sistema, a chi ruba i conflitti”.
– In questo quadro, che cosa dire del ruolo dei media?
“Credo che il più significativo sia quello della televisione che, innanzitutto, riduce il nostro tempo sociale, la partecipazione alle varie attività che ci fanno stare insieme con gli altri. Inoltre, come noto, i mass media sovraespongono i fatti criminali, li rendono talmente centrali da spaventare la gente. E la gente spaventata alimenta il circolo vizioso, se ne sta di più a casa a guardare la tv, fuori un deserto buio. Se guardiamo i dati della polizia sulla criminalità notiamo che tutte le tipologie sono in crescita, a parte il reato d’ingiuria: brutto segno, la gente non si interessa più degli altri… Ci vorrebbero nuovi spazi di riflessione, dibattiti veri e non le cose <primitive> che ci offrono oggi politici e mass-media”.
– Un consiglio ai giornalisti?
“Per esempio andare a seguire una seduta alla Camera dei conflitti. Vedrebbero che spesso a soffrire sono sia la vittima sia l’accusato che magari non riesce a capire quanto grave sia stata (per la parte lesa) la sua azione e cerca di spiegarsi. Lì i giornalisti si renderebbero conto di come, piano piano, con il dialogo, le due persone cercano di farsi capire. La vittima comincia un po’ alla volta a rendersi conto che l’aggressore è una persona normale; questi comincia a capire quel che ha combinato. Può finire con una stretta di mano e questo mi sembra l’epilogo moralmente più accettabile; di sicuro più di affidare la pratica a un funzionario del sistema penale. In una piccola area dell’Australia in questo periodo è in corso un esperimento che coinvolge l’intera popolazione sulla questione del conflitto e della partecipazione: così si può costruire una nuova consapevolezza.
– Una parte delle persone in carcere non ripeterebbe l’atto per il quale sono state punite; un’altra parte, probabilmente sì. Ha senso cercare di mettere a fuoco questa distinzione per determinare l’esistenza di una minoranza di individui che potrebbero potenzialmente reiterare, per esempio, azioni violente?
“Non si riuscirebbe mai a capire chi sarebbero i componenti di questa minoranza. Credo che la scelta della detenzione si possa immaginare solo quando fallisce del tutto la mediazione; oppure nei singoli casi di azioni violente così raccapriccianti da far ritenere che il cittadino medio non accetterebbe una condizione diversa per l’imputato. Torniamo agli aspetti culturali. Va tenuto conto, però, che rinchiudere una persona in carcere aumenta la probabilità di reiterazione del reato una volta scontata la pena. Ricordo spesso che se mandiamo i nostri figli a scuola è perché pensiamo che lì imparino delle cose e abbiano una vita sociale; che cosa significa, invece, mandarli in prigione? Come saranno quando usciranno? O vogliamo forse avere dei giganteschi campi di concentramento in cui si entra e non si esce più?”.
– C’è chi difende il carcere come strumento preventivo, la pena come deterrente…
“E’ molto bassa la probabilità che una persona non compia un’azione perché un altro individuo è stato incarcerato per un atto analogo. Quando uno perde il controllo non pensa certo né al codice penale né a chi sta in cella. E nemmeno chi agisce per un bisogno economico (per esempio, un contadino colombiano che decide di coltivare o trasportare cocaina) o in base a meccanismi di gratificazioni di un ambiente degradato in cui la violenza è l’unico mezzo per emergere. Insomma, si tratta di una battaglia culturale su più fronti”.
– In altre parole, siamo tutti potenziali criminali, dipende dall’ambiente…
“Ho analizzato a lungo i norvegesi che facevano le guardie nei campi di lavoro nazisti nella Norvegia settentrionale, dove i prigionieri, molti dei quali erano serbi, spesso morivano di stenti. Quelle guardie erano persone normali: pensavano semplicemente che i prigionieri, i “nemici”, erano delle bestie, non degli esseri umani… Uno dei sopravvissuti, un serbo, mi ha raccontato che deve la vita a una fatalità: l’aver trovato nel campo un vocabolario tedesco-norvegese che si studiò parola per parola nelle lunghe ore passate in cella. Un giorno mentre il prigioniero marcia in fila indiana nel cortile, la guardia norvegese in testa alla colonna chiede a quella in fondo se ha un fiammifero, un “fyrstikk”; l’altra risponde di no; il serbo allora dice: “Jeg har en fyrstikk”, io ho un fiammifero, e da quel giorno non fu l’unico a non essere trattato come un mostro…”.
 La decisione presa dal presidente USA Donald Trump di riconoscere la città contesa di Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele e di spostare in quella città l’ambasciata statunitense in Israele ha scatenato non solo una serie di proteste formali da parte dei governi di mezzo mondo, ma hanche rinfocolato un conflitto, quello fra Israele e Palestina, che non necessitava certo di questa nuova doccia di benzina su un fuoco che arde ormai da almeno ottant’anni. Perchè Trump abbia deciso di sposare l’idea di Gerusalemme capitale se lo chiedono in molti, diversi analisti e commentatori hanno provato a dare una risposta al quesito. Forse che, fallito per ora lo scontro nucleare col rivale nordcoreano Kim Jong “Bimbominkia” Un, Donald “Er Pannocchia” Trump si consoli seminando l’ennesimo casino in Medioriente per poter trascorrere le feste natalizie in modo un pò meno noioso del solito? Battute a parte, le ragioni di questa mossa andrebbero principalmente cercate nella volontà statunitense di recuperare terreno nella competizione imperialista in Medioriente rispetto alla Russia, Paese che finora sembra aver guadagnato più punti d’influenza in seguito all’esito del conflitto militare in (e intorno alla) Siria.
La decisione presa dal presidente USA Donald Trump di riconoscere la città contesa di Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele e di spostare in quella città l’ambasciata statunitense in Israele ha scatenato non solo una serie di proteste formali da parte dei governi di mezzo mondo, ma hanche rinfocolato un conflitto, quello fra Israele e Palestina, che non necessitava certo di questa nuova doccia di benzina su un fuoco che arde ormai da almeno ottant’anni. Perchè Trump abbia deciso di sposare l’idea di Gerusalemme capitale se lo chiedono in molti, diversi analisti e commentatori hanno provato a dare una risposta al quesito. Forse che, fallito per ora lo scontro nucleare col rivale nordcoreano Kim Jong “Bimbominkia” Un, Donald “Er Pannocchia” Trump si consoli seminando l’ennesimo casino in Medioriente per poter trascorrere le feste natalizie in modo un pò meno noioso del solito? Battute a parte, le ragioni di questa mossa andrebbero principalmente cercate nella volontà statunitense di recuperare terreno nella competizione imperialista in Medioriente rispetto alla Russia, Paese che finora sembra aver guadagnato più punti d’influenza in seguito all’esito del conflitto militare in (e intorno alla) Siria.