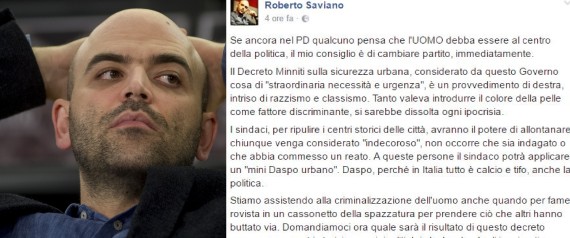Che il referendum sul’indipendenza catalana indetto per il prossimo 1 Ottobre abbia successo o meno, a prescindere dal fatto che un suo esito eventualmente positivo non venga riconosciuto dalle istituzioni dello Stato spagnolo, vorrei abbozzare alcune considerazioni generali, dal mio personale punto di vista di anarchico, sulla questione specifica dell’indipendentismo catalano e, piú diffusamente, sull’indipendentismo in generale, partendo da un presupposto libertario. Premetto che non è facile farsi rapidamente un’idea delle dinamiche che agitano gli animi dei fautori dell’indipendenza catalana e dei loro avversari unionisti. Ritengo che un buon punto di partenza sia la lettura dell’articolo pubblicato sul sito Sollevazione col titolo “La Catalogna, la Spagna e l’Unione Europea” che, da un punto di vista fortemente critico nei confronti dell’indipendenza catalana da una prospettiva di sinistra “radicale” e antieuropeista, spiega in maniera abbastanza approfondita chi e perchè sostiene il referendum sull’indipendenza catalana e chi e perchè vi si oppone, contestualizzando in particolare il rapporto degli indipendentisti con l’Unione Europea. Di articoli su questo tema se ne trovano molti altri, di diverse tendenze, sul web e su carta e, se ci si vuol fare un’opinione con un minimo di fondamento, se ne dovrebbero selezionare, leggere e confrontare parecchi. Due libri segnalati come interessanti che trattano la questione catalana sono: Elena Marisol Brandolini, Catalunya – España, il difficile incastro, Roma, Ediesse, 2013 e Angelo Attanasio e Claudia Cucchiarato, La questione catalana. Independéncia?, GoWare, 2013 [e-book].
Che il referendum sul’indipendenza catalana indetto per il prossimo 1 Ottobre abbia successo o meno, a prescindere dal fatto che un suo esito eventualmente positivo non venga riconosciuto dalle istituzioni dello Stato spagnolo, vorrei abbozzare alcune considerazioni generali, dal mio personale punto di vista di anarchico, sulla questione specifica dell’indipendentismo catalano e, piú diffusamente, sull’indipendentismo in generale, partendo da un presupposto libertario. Premetto che non è facile farsi rapidamente un’idea delle dinamiche che agitano gli animi dei fautori dell’indipendenza catalana e dei loro avversari unionisti. Ritengo che un buon punto di partenza sia la lettura dell’articolo pubblicato sul sito Sollevazione col titolo “La Catalogna, la Spagna e l’Unione Europea” che, da un punto di vista fortemente critico nei confronti dell’indipendenza catalana da una prospettiva di sinistra “radicale” e antieuropeista, spiega in maniera abbastanza approfondita chi e perchè sostiene il referendum sull’indipendenza catalana e chi e perchè vi si oppone, contestualizzando in particolare il rapporto degli indipendentisti con l’Unione Europea. Di articoli su questo tema se ne trovano molti altri, di diverse tendenze, sul web e su carta e, se ci si vuol fare un’opinione con un minimo di fondamento, se ne dovrebbero selezionare, leggere e confrontare parecchi. Due libri segnalati come interessanti che trattano la questione catalana sono: Elena Marisol Brandolini, Catalunya – España, il difficile incastro, Roma, Ediesse, 2013 e Angelo Attanasio e Claudia Cucchiarato, La questione catalana. Independéncia?, GoWare, 2013 [e-book].
Ed eccomi arrivato alle mie considerazioni sulla faccenda, riassunte schematicamente:
Indipendentismo, una panacea per tutti i mali. La politica dei partiti tradizionali e del governo centrale corrotto, incompetente e distante dai tuoi interessi ti delude? Sei in balia di una crisi economica che mette in dubbio quel che finora sembrava certo? Non ti senti padrone di decidere della tua vita e intorno a te serpeggia il malumore di altri insoddisfatti? La soluzione indipendentista, fermo restando i presupposti storico-culturali (se non ci sono si inventano dal nulla, come in “Padania”), potrebbe fare a caso tuo! Almeno questo è quello che ti raccontano i venditori di fumo interessati a trarre vantaggio dal riassetto istituzionale in questione. Non metto in dubbio che tra i sostenitori di una qualsiasi secessione ci siano anche persone benintenzionate e in buona fede, ma queste persone solitamente antepongono l’emotività al discorso razionale e tendono ad adeguare la realtà alle proprie opinioni e aspettative e non viceversa. Secondo me chiunque ha il diritto di autodeterminarsi, il che va ben oltre qualsiasi dichiarazione di voler rendere indipendente una regione da un’altra. Io intendo l’autodeterminazione come un processo di libero sviluppo della propria persona, di libera scelta riguardo i più disparati aspetti della propria esistenza.
A propugnare l’indipendenza della Catalogna dal resto della Spagna sono partiti di diversa tendenza e ispirazione, ma soprattutto persone di condizione sociale ed economica molto diversa fra loro. Su quest’ultimo aspetto non si può sorvolare. Che interessi comuni hanno il proprietario di una catena di alberghi e un lavapiatti? L’uno è lo sfruttatore dell’altro, lo è oggi anche grazie alle leggi spagnole e lo sarebbe ugualmente in un ipotetico futuro grazie alle leggi di uno Stato catalano. Se gli indipendentisti volessero fare una rivoluzione sociale abolendo il capitalismo e sostituendolo con modelli economici collettivisti/comunitari/solidali (cosa che, a ben guardare, ben pochi tra loro sognano) non perderebbero tempo sperando di vincere un referendum per il riconoscimento legale di un nuovo Stato sottomesso fin dalla sua nascita alle politiche del neoliberismo globale. Alla classe politica non interessa certo perdere i privilegi dei quali gode, né i capitalisti catalani sono smaniosi di rinunciare ai loro profitti perdendo competitività sui mercati, soccombendo alla concorrenza o lasciandosi addirittura togliere i mezzi con i quali sfruttano chi lavora per loro. Combattere al fianco del tuo nemico ha senso solo se tu lo ritieni piuttosto un alleato col quale far causa comune in nome dell’obiettivo principale che persegui, in questo caso un nuovo Stato. Competitivo, forte sui mercati, capace di crescita economica, politicamente e socialmente stabile. Il tutto condito con sangue e sudore dei lavoratori che hanno abdicato alla loro coscienza di sfruttati e oppressi in cambio di nuove catene.
“Ma abbiamo le stesse radici culturali!”, mi son sentito dire parecchie volte da indipendentisti di varia provenienza. Che differenza fa se a picchiarti è un bastone rosso o un bastone nero?, rispondo io riecheggiando Bakunin. E che differenza fa se chi ti spreme via tempo, forze e intelligenza a proprio vantaggio è nato nella tua stessa città, parla la tua stessa lingua, se amate gli stessi piatti tipici, professate lo stesso culto religioso e festeggiate le stesse ricorrenze? A parte il fatto che la cultura si crea e si modifica, non mi sembra un requisito fondamentale sul quale costruire alleanze o peggio in nome del quale scannarsi.
Eppure, un tempo si parlava di popoli e nazioni oppresse. Almeno in campo marxista era un dato di fatto indiscusso, come ricorda Steven Forti in un articolo ripreso da “A-Rivista Anarchica” del Dicembre 2013-Gennaio 2014: “In Irlanda, per il Marx maturo, non c’era una questione sociale al di fuori di una questione nazionale. Anche l’ultimo Engels sottolineò in più occasioni come l’internazionalismo del proletariato era possibile solo se esistevano nazioni indipendenti. La posizione di Lenin, ribadita più chiaramente nel Congresso dei popoli oppressi tenutosi a Baku nel 1920, era stata resa esplicita già nel 1916: “Credere che la rivoluzione sociale sia immaginabile senza le insurrezioni delle piccole nazioni nelle colonie e in Europa (…) significa rinnegare la rivoluzione sociale”.
Anche Mao, almeno a partire dalla Lunga Marcia iniziata nel 1934, dimostra posizioni orientate ancora di più in questa direzione: “nella lotta nazionale, la lotta di classe assume la forma di lotta nazionale; e in questa forma si manifesta l’identità tra le due lotte”. Ovvero: “Nella guerra di liberazione nazionale, il patriottismo è perciò un’applicazione dell’internazionalismo”. Lasciando da parte sia le ovvie considerazioni riguardo l’incoerenza dei pessimi epigoni di Marx nell’applicare il principio di autodeterminazione dei popoli, sia le funeste conseguenze degli ossimorici “socialismi di Stato”, mi chiedo se nel caso della Catalogna si tratti di una lotta di liberazione dallo stato centrale e non, come invece sembrerebbe, un caso di sciovinismo bell’e buono. La Catalogna infatti è fra le regioni più benestanti della Spagna, parte degli indipendentisti ritengono che starebbero meglio economicamente se avessero un loro Stato (lo conferma lo studio di un’associazione imprenditoriale catalana favorevole all’indipendenza, lo smentiscono tutte le fonti vicine al governo di Madrid). Perciò via i pesi morti, avanti i più forti. Il tutto in un’ottica borghese di sciovinismo del benessere, mentre la solidarietà e le lotte comuni con qualsiasi sfruttato ed oppresso spagnolo, immigrato o che vive, lavora e lotta altrove vanno a farsi friggere.
Mentre pure un’organizzazione che era marxista e autoritaria come il PKK ha cambiato da diversi anni visione e obiettivi e tenta oggi di realizzare, insieme ad altre forze politiche, sociali e militari non l’indipendenza di uno Stato-nazione, ma l’autonomia di una regione, il Rojava, in chiave multietnica e sotto la bandiera del confederalismo democratico di ispirazione libertaria, devo tristemente constatare che altrove c’è chi ancora si attacca all’idea di Stato. C’è da riflettere anche sulle affermazioni fatte da un militante catalano del sindacato anarchico spagnolo CNT durante un’intervista di due anni fa, pubblicata da Umanità Nova. Se da un lato rimane inamovibile il rifiuto di qualsiasi Stato, d’altra parte si lascia intravedere la possibilità circa un miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita sociale in un nuovo Stato catalano. Da dove scaturisca quest’ottimismo non è dato saperlo. Di certo, se i presagi non ingannano, comunque vada il referendum sull’indipendenza catalana, le istituzioni spagnole non sono disposte a riconoscerlo e già fanno di tutto per sabotarlo, incluso minacciare di portare in tribunale i sindaci catalani che ne autorizzeranno lo svolgimento nei loro comuni. Resta da vedere fino a che livello si innalzerà lo scontro fra Madrid e i separatisti e se questo offrirà spazi per l’espressione di forme di conflittualità che vadano oltre le mere rivendicazioni sovraniste.